Capire ciò che vediamo, conoscere ciò di cui scriviamo
Scritto da Alberto Cassani lunedì 1 febbraio 2016
Archiviato in Cinema d'attualità, Quelli che scrivono...

Qualche anno fa mi capitò di avere un’accesa discussione con il tenutario e alcuni frequentatori di un blog che si occupava saltuariamente di cinema. Materia del contendere era la conoscenza specifica che avevano alcuni critici cinematografici italiani, e ragione della discussione era la mia bassa opinione di alcuni nomi tenuti invece in grande considerazione da parte dei miei interlocutori. Quali fossero i nomi in discussione e come si sia concluso lo scambio non ha importanza, né ha importanza se io nel caso specifico avessi ragione o torto. Il punto è che – se è lecito aspettarsi da parte di un critico una buona conoscenza della tecnica e del linguaggio cinematografico – purtroppo non sempre è così. E cosa ancor più grave, purtroppo non è così nemmeno quando si parla di critici importanti e in qualche modo influenti.
Ai semplici appassionati potrebbe sembrare che, per fare il nostro lavoro, una conoscenza della tecnica cinematografica sia meno importante di quella storica. Che vedere tanti film sia più importante di capire come sono stati realizzati. Non è così. Come ogni altra forma di espressione, il cinema è dotato di un suo linguaggio tecnico ben preciso, di una vera e propria grammatica. Come non sarebbe accettabile un critico letterario o un insegnante di lingue che non distingue un verbo da un aggettivo, così non è accettabile un critico cinematografico o un insegnante di cinema che non distingue una carrellata in avanti da una zumata. Vuol dire non essere in grado di capire ciò che si vede, vuol dire non avere idea di come si svolge il processo creativo alla base di un film, vuol dire non poter contestualizzare le scelte che vengono fatte nel processo di realizzazione. Può persino voler dire non riuscire neanche a capire che queste scelte sono state fatte.

Ho già avuto modo in passato di dedicare spazio al fenomeno delle recensioni cinematografiche scritte sui grandi quotidiani nazionali da esperti di altri settori. E’ un’abitudine che nega a monte la specificità del cinema e che impedisce al lettore di apprendere qualcosa del suo linguaggio. Che un giornalista politico non riesca a distinguere un effetto speciale digitale da uno meccanico è anche comprensibile, quello che non è comprensibile è che il suo direttore ritenga che non sia necessario farlo per poter scrivere di cinema con cognizione di causa. Così facendo si offre un pessimo servizio innanzi tutto ai propri lettori (che sono la vita dei giornali e dei giornalisti) e in seconda battuta al cinema stesso. Purtroppo la cosa grave è che, come accennavo all’inizio, questa stessa incompetenza è comune anche a tanti critici professionisti, anche di nome. Non ci credete? Paolo Mereghetti, l’unico critico cinematografico italiano realmente riconoscibile, ne ha dato prova nella sua recensione a The Hateful Eight di Quentin Tarantino, pubblicata sul Corriere della Sera il 29 Gennaio. Al di là del giudizio di merito sul film, Mereghetti a un certo punto scrive:
La pellicola 70 mm (in Italia visibile solo in due locali, a Melzo e Bologna) restituisce una straordinaria profondità all’inquadratura ma quando serve solo per mostrare un occhio tumefatto, un paio di baffi molto folti o una chiostra di denti ultra bianchi, ti chiedi se non sei davanti a una montagna che ha partorito solo un topolino.
Mereghetti sta parlando di profondità di campo, ossia – citando la sesta edizione dell’American Cinematographer Manual, stampata nel 1986 dal sindacato statunitense dei direttori della fotografia cinematografica – ciò che…
…definisce la regione davanti e dietro il piano principale dell’inquadratura in cui un oggetto fotografato ha un’immagine sufficientemente nitida. […] Il limite più vicino e quello più lontano non sono distanze alle quali l’immagine diventa improvvisamente a fuoco o fuori fuoco, ma piuttosto limiti che, quando superati, risulteranno progressivamente in immagini inaccettabilmente confuse.
In pratica, con profondità di campo si indica lo spazio su un set in cui tutti gli oggetti ripresi dall’inquadratura sono a fuoco. Il sito Nikon School ha un ottimo tutorial sull’argomento. Vi invito a leggerlo per approfondire, se ne avete bisogno, poiché qui mi basta estrapolare una singola frase per farvi capire perché ciò che ha scritto Mereghetti è sbagliato:
Come il diaframma, la distanza di messa a fuoco e la lunghezza focale possono cambiare ciò che apparirà nitido
L’ampiezza della profondità di campo dipende da tre cose: l’obiettivo usato, quanta luce si permette che vi passi attraverso al momento dello scatto e a che distanza ci si trova dal soggetto principale dell’inquadratura.
E’ vero che ci sono altri fattori che influiscono sulla nitidezza dell’immagine – e il formato della pellicola è tra questi, insieme anche all’illuminazione della scena – ed è vero che Tarantino in questo film usa spesso la profondità di campo per avere a fuoco sia il soggetto sia lo sfondo. Quello che non è vero è che l’abbia potuto fare grazie alla pellicola.
La pellicola 70mm offre (offriva…) rispetto a quella classica in 35mm una maggior definizione dell’immagine, per il semplice fatto di avere un fotogramma largo il doppio e di usare lenti anamorfiche che “strizzano” meno l’immagine, così da poter catturare la luce con maggior precisione. Pensate a due foto stampate in dimensioni diverse: ovviamente in quella più grande noterete meglio i particolari, ma un oggetto fuori fuoco sarà fuori fuoco comunque, e allo stesso modo un oggetto a fuoco lo sarà anche nella foto più piccola.
I due fotogrammi qui sopra (che potete vedere più in grande con un semplice click) sono presi rispettivamente da I sogni segreti di Walter Mitty – girato con il formato Panavision 35mm usato comunemente nel cinema moderno – e Intrigo internazionale, girato in VistaVision 35mm con lenti sferiche (ossia che non strizzano l’immagine, impressionando però in questo caso l’equivalente di due fotogrammi contemporaneamente). In entrambi i casi il risultato è esattamente lo stesso ottenuto in The Hateful Eight, ve ne potete rendere conto anche solo guardando la foto di scena del film di Tarantino che ho inserito più sopra.
Ma siamo buoni: vogliamo dire che Tarantino ha potuto ottenere questo effetto nell’ambiente relativamente buio in cui ha ambientato la sua storia grazie alla capacità della pellicola 70mm di catturare meglio la luce? Ok, diciamolo. Nella seconda parte della sua frase, però, Mereghetti scrive che Tarantino usa la profondità dell’inquadratura «solo per mostrare un occhio tumefatto, un paio di baffi molto folti o una chiostra di denti ultra bianchi». Probabilmente sta allora pensando a questa inquadratura e ad altre similari:

Un’inquadratura che però non fa assolutamente uso della profondità di campo, avendo un solo elemento nel frame. In realtà gli unici momenti del film in cui si ha una profondità di campo fuori dal comune, sono quelli che Tarantino e il direttore della fotografia Robert Richardson hanno realizzato utilizzando un trucco ottico.
E’ un tipo di inquadratura che ad esempio Brian De Palma ha usato spesso lungo tutta la sua carriera, che Robert Wise ha utilizzato come precisa scelta stilistica in Star Trek – Il film e che lo stesso Tarantino ha proposto in molte delle sue pellicole precedenti, sin dal suo esordio. Come detto non sono inquadrature in profondità di campo, bensì in doppia focalità, com’è evidente (nonostante la bassa risoluzione degli screenshot qui sopra) dagli elementi completamente fuori fuoco quando non dovrebbero esserlo: la caffettiera nella prima inquadratura sullo stesso piano del personaggio, la parete nella parte sinistra della seconda inquadratura e quella nel centro della terza.
I 5 fotogrammi che seguono sono altri esempi relativamente recenti in cui è utilizzato lo stesso meccanismo, e in cui la manipolazione della messa a fuoco è abbastanza evidente dagli elementi palesemente sfocati. Il più evidente è proprio il fotogramma di Le iene, dov’è chiaramente visibile la linea che delimita i due piani focali.
Se in un’inquadratura con profondità di campo un soggetto in primo piano è a fuoco ed è a fuoco anche un soggetto sullo sfondo, sarà automaticamente a fuoco anche tutto ciò che c’è in mezzo tra questi due piani. Nelle inquadrature in questione, invece, è stata montata sulla macchina da presa quello che una volta era chiamato “diottro bifocale” e che viene invece oggi definito “lente split field” (in inglese “split diopter”), ossia un filtro che aggiunge all’obiettivo metà di una lente convessa.

Grazie a questa mezza lente, il diopter permette di mettere a fuoco contemporaneamente due piani diversi in due parti diverse dell’inquadratura. Ma tutto ciò che non si trova sul piano a fuoco di quella mezza inquadratura risulterà fuori fuoco, compresi gli oggetti che sono sul piano di fuoco dell’altra metà dell’inquadratura. Per vedere come viene messo in pratica questo effetto, potete guardare questo breve ma chiarissimo video.
A seconda della composizione dell’inquadratura si può cercare di mascherare la sfasatura tra i due piani in modo da far apparire la ripresa il più naturale possibile, come nell’immagine tratta da Tutti gli uomini del Presidente. In questo caso è ovvio pensare che il diopter sia stato usato perché non c’erano le condizioni per ottenere una profondità di campo sufficiente a coprire entrambi i piani: nel film di Alan J. Pakula probabilmente non c’era abbastanza spazio per stare sufficientemente lontani da Robert Redford e avere a fuoco anche il gruppo di giornalisti in fondo alla stanza, ma può capitare anche di dover girare in ambienti troppo bui per permettere di tenere il diaframma sufficientemente chiuso. Al contrario, si può sfruttare l’effetto della lente aggiuntiva proprio per dare all’immagine un senso straniante, come fa di solito De Palma.
Ad ogni modo, si tratta come detto di un effetto che Tarantino ha utilizzato spesso, ma che non ha probabilmente mai usato tanto come in The Hateful Eight, tanto da farne l’effetto visivo su cui si basa tutta la risoluzione dell’intreccio Se si vuole parlare delle particolarità visive di questo film non si può farlo senza spiegare cosa l’Ultra Panavision 70 offre davvero rispetto alla Panavision 35mm (immagini più nitide e inquadratura più larga di un sesto) e senza almeno accennare allo split field. Certo, per poterlo fare bisognerebbe sapere di cosa si sta parlando…
Percorsi tematici
Commenti
11 risposte a: “Capire ciò che vediamo, conoscere ciò di cui scriviamo”
Lascia un commento
Devi fare log in per poter inserire un commento.









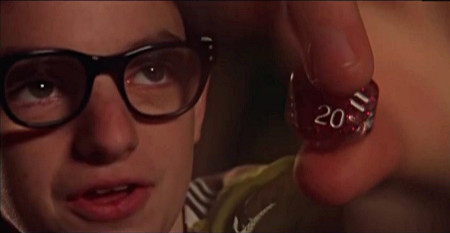

Tutto il discorso che fai sulla profondità di campo è interessante. E io amo la profondità di campo (anzi, amo la sua mancanza, tant’è vero che i miei obiettivi sono sempre settati alla massima apertura possibile dell’otturatore). Però non vorrei che Mereghetti intendesse altro: magari ha usato “profondità” come sinonimo di “dettaglio” o di “definizione” o di “qualità”.
Lo dico perché mi sembra molto strano che Mereghetti non sappia cos’è un concetto base come la profondità di campo.
Il discorso è un po’ diverso da quello che facevi tu su zumata/carrello o effetto ottico/digitale. Per riconoscere queste differenze bisogna avere un minimo di esperienza, sapere magari come si modifica la prospettiva nel caso della zumata e cose del genere.
Ma la pdc è un concetto davvero basilare che chiunque abbia preso in mano una macchina fotografica ha avuto modo di sperimentare. Non può non sapere cosa sia!
Ma infatti non ho detto che Mereghetti non sa cosa sia la profondità di campo, ma che qui ne ha frainteso le ragioni. Ho scritto semmai che secondo me non sa nemmeno dell’esistenza del diopter… Se poi invece è come dici tu e lui usa “risotto” come sinonimo di “spaghetti”, poi non può lamentarsi che al ristorante non gli portano quello che ha ordinato.
Mereghetti o meno, l’articolo risulta assai interessante.
Ne sono felice. Lo scopo era proprio questo: non solo criticare ciò che Mereghetti ha scritto, ma spiegare in maniera chiara ai lettori qualcosa di importante che magari non sanno.
Spero che i tuoi colleghi scrivano un sacco di corbellerie allora… 😉
Grazie per le spiegazioni. Ho letto l’articolo del Corsera ma simceramente credo che Mereghetti sua state troppo severo. Immagino che non possa esistere una idea unica di cosa sia il cinema. Esso si evolve e a volte raccoglie dal basso le sue ispirazioni, teno che Merghetti volesse recensire un Tiziano e si sia trovato davanti ad un Warhol
Non mi interessava più di tanto confutare la correttezza dell’opinione generale di Mereghetti sul film, quanto far capire che le ragioni che lui espone in recensione come la base del giudizio critico che esprime sono sbagliate. Poi lui è notoriamente avverso a Tarantino e al cinema tarantiniano, e l’impressione leggendo questa recensione è anche un po’ che sia entrato in sala con forti preconcetti e abbia scritto in modo da confermarli.
Arrivo qui a distanza di mesi,ma lo dico lo stesso: “entrare in sala con forti preconcetti e scrivere in modo da confermarli” è quanto di peggio possa fare un critico che si possa definire tale.
E’ chiaro che non è facile separarsi da sè stessi, mai, ma è ben per questo che la competenza nell’uso degli strumenti di analisi impedirebbe posizioni umorali e inutili personalismi. E il rispetto del lettore/spettatore sarebbe salvo, cosa che non guasterebbe affatto!
Quanto all’importanza di dotarsi di un linguaggio appropriato e filologicamente corretto concordo in pieno, inutile dirlo,non capisco perchè (o forse lo capisco troppo bene) proprio sul cinema e non su altre forme d’arte si sia scatenata questa corsa strampalata alla critica, comunque e dovunque.E’ l’effetto internet? Può darsi, ma letteratura, musica, arti visive non hanno subito lo stesso fenomeno e il web esiste anche per loro.
Nessuno spettatore, nemmeno il critico, può estraniarsi completamente da se stesso, quando entra in sala. Ma se è comprensibile e anche apprezzabile che uno spettatore valuti un film secondo il proprio vissuto, un critico dovrebbe invece avere la capacità e la serietà professionale di mettere da parte se stesso quando poi racconta il film in sede di recensione. Ma questo non succede quasi mai, né in positivo né in negativo.
Purtroppo la non proprietà di linguaggio e più in generale l’approssimazione con cui la critica cinematografica ha sempre scritto, unita alla deriva acritica che ha subito negli ultimi vent’anni, è secondo me la ragione principale dell’importanza nulla che la critica ha oggi agli occhi dei lettori. Si usa dire che una volta il pubblico faceva la fila per vedere Fellini e Pasolini, io uso dire che ha smesso di fare la fila perché la critica non gli ha mai spiegato perché quei film valevano la pena di essere visti. Oggi poi, con il web, si è acuito enormemente l’effetto “se lo fa lui posso farlo anch’io”, e quindi via di siti e blog di critica cinematografica realizzati da gente che il cinema lo conosce solo come spettatore, perché hanno l’impressione che i critici professionisti non abbiano alcuna conoscenza più di loro. E non poche volte hanno anche ragione…
Mi permetto una piccola critica al critico. La distanza dell’oggetto dall’obiettivo definisce se l’oggetto è a fuco o meno, ma non definisce la profondità di campo. I fattori sono la focale, il diaframma e la dimensione del fotogramma (il format insomma). La stessa focale e lo stesso diaframma riproducono una profondità di campo più ampia se l’inquadratura viene catturata ad esempio con un sensor da 1/3″ invece che con un full frame – o in Super 8 invece che in 35mm. Inoltre sono del parere che una vasta conoscenza tecnica non aiuti tanto se si tratta di analizzare un film allegorico come ad esempio Vinyan di Fabrice du Welz, Possession di Andrzej Zulawski o Singapore Sling di Nikos Nikolaidis. Dei Film come The Hateful Eight si concentrano sulla tecnica. Perciò un’analisi tecnica ha senso, mentre un tale approccio per Possession sarebbe parecchio inutile perché ciò che conta è il contenuto, non il suo linguaggio. Truffaut ha parlato di questo nel suo articolo sui Cahiers du cinéma nel 1954, Fassbinder l’ha confermato all’inizio degli anni 1970 e Dogma 95 è stato un ulteriore tentativo di ridurre la tecnica a favore del messaggio del film. In un certo senso pure Robert Rodriguez ci tiene conto quando paragona la creatività con la tecnica nella sua 10 minute film school. A mio parere almeno – i pareri personali sono sempre discutibili. Grazie comunque di questo articolo. Concordo con tanti altri dei suoi aspetti.
Patrick, volendo semplificare per i profani mi rendo conto di aver scritto una cosa ambigua. Se metto a fuoco un punto, avrò una determinata profondità di campo, ma se ne metto a fuoco un altro la profondità di campo cambia. Per questo bisogna considerare nell’equazione anche la distanza dal punto di messa a fuoco, ma ovviamente questo non influisce di per sé sulla profondità di campo.
È vero quello che dici sulle differenze tra un film e l’altro, ma una delle capacità principali necessarie a un critico cinematografico è proprio il saper capire che strumenti usare per analizzare un determinato film. Va però detto, e questa è una cosa su cui io insisto sempre molto, che qualunque cosa un registra voglia fare nel proprio film, deve farla sempre e comunque attraverso la tecnica. Il cinema ha un suo linguaggio, una sua grammatica, e anche solo per decidere di ignorare determinate regole di questa grammatica, bisogna conoscerle e sapere come applicarle. Anche Steven Soderbergh diceva che le scuole di cinema non servono, perché se uno ha talento e creatività gli basta prendere in mano la macchina da presa e andare per strada a girare, ma questo presuppone comunque una conoscenza del cinema da parte del regista, e quindi – inconsciamente, senza nemmeno rendersene conto – delle sue regole. Poi, ripeto, quando non serve analizzare la tecnica non serve e non lo si deve fare, però la sua conoscenza – da parte del critico come del regista – è comunque necessaria.